Ogni invio è una preghiera laica
C’è un istante preciso in cui le dita esitano sul tasto “invia”.
Una pausa sospesa tra la speranza e la paura, tra il desiderio di cambiare qualcosa e la consapevolezza che quel “qualcosa” potrebbe restare, comunque, troppo grande da abbracciare.
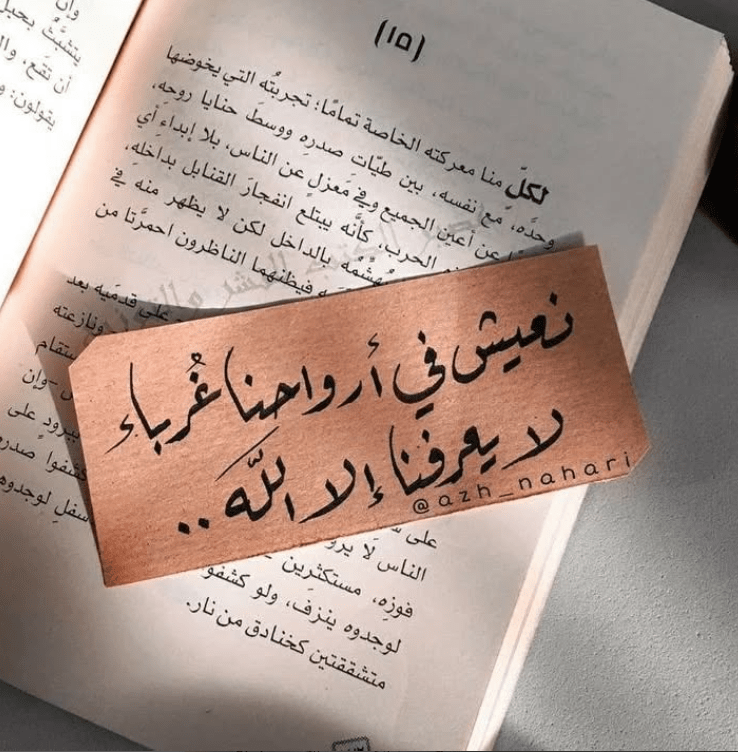
Ieri ho premuto quel tasto per inviare la candidatura del mio amico Nedam, un ragazzo ventunenne palestinese che vive sotto assedio nel nord di Gaza, al bando “Studenti a rischio” dell’Università di Trento.
Un modulo, qualche documento tradotto, alcune righe scritte in inglese: frammenti di un futuro possibile.
Dietro quella domanda c’è lo sforzo di settimane: la ricerca di certificati dispersi sotto le macerie, i messaggi interrotti da un blackout, la connessione che salta improvvisa — e poi riparte.
C’è il desiderio, ostinato, di non arrendersi all’assurdo della guerra.
Mentre compilavo le ultime carte, ho inviato una piccola donazione. Dopo pochi minuti, Nedam mi ha scritto:
“Grazie, ho comprato la farina per la mia famiglia.”
La concretezza disarmante di questo gesto — la farina come simbolo della vita stessa — mi ha colpita più di qualsiasi parola.
In quella realtà, dove ogni giorno è una lotta per la sopravvivenza, è difficile pensare al futuro.
Eppure, per un ragazzo della sua età, sognare il futuro dovrebbe essere la cosa più naturale del mondo: progettare, costruire, scegliere chi diventare.
Ma oggi, per Nedam, ogni sogno è legato ai bisogni più elementari, quelli alla base della piramide di Maslow: cibo, acqua, sicurezza.
Non dovrebbe essere così.
Nessun giovane dovrebbe misurare la propria speranza in sacchi di farina.
Poco dopo, un altro bombardamento è caduto vicino a casa loro.
Per fortuna stanno bene, ma ogni volta il confine tra la vita e la perdita si assottiglia.
E quando accadono questi momenti, e le comunicazioni su WhatsApp si interrompono, mi sale l’angoscia.
Controllo ossessivamente il telefono, sperando in un messaggio, anche solo un “We’re okay”.
Finché non arriva, il respiro resta sospeso, come se anche l’aria avesse paura di muoversi.
Scrivere, per me, è spesso un atto di cura. Ma stavolta non bastano le parole.
Servono mani, reti, coraggio.
Servono persone che decidano di esserci, anche solo per un istante, anche solo con un gesto.
Comprendo la diffidenza di molti, la sensazione di impotenza e quell’immobilismo che nasce davanti all’immensità della catastrofe — perché sì, è difficile credere di poter cambiare qualcosa.
Ma qualcosa dobbiamo fare.
Perché l’azione, anche minima, è ciò che ci salva dal silenzio.
E in ogni gesto di cura, anche piccolo, c’è una scelta: quella di non voltarsi dall’altra parte.
La solidarietà non è un privilegio: è la possibilità di restare umani.
Quando scegliamo di donare — tempo, attenzione, denaro, voce — non stiamo solo aiutando qualcuno: stiamo ricordando a noi stessi da che parte vogliamo stare.
Ciò che sta accadendo a Gaza è molto più che una tragedia lontana:
è il segno dei nostri tempi, tempi in cui abbiamo imparato, troppo bene, l’indifferenza.
Un’indifferenza che si insinua nelle pieghe del quotidiano, nei pensieri distratti, nei “non posso farci nulla”.
Io non ci sto.
Come formatrice, è mio dovere combatterla.
Educare, per me, significa ricordare che ogni essere umano è “materia sacra” di relazione, empatia, ascolto.
Significa allenare alla responsabilità, alla consapevolezza, alla cura.
C’è chi salva una vita, e chi prova almeno a salvarne la dignità.
A volte basta guardare negli occhi chi chiede e dire, semplicemente: “Ti vedo.”
Oggi, ogni piccolo aiuto per Nedam e per la sua famiglia diventa un modo concreto per trasformare la paura in nutrimento, l’attesa in possibilità.
Chi vuole può contribuire scansionando il QR code: un segno piccolo, ma pieno di significato.
Perché nessuno dovrebbe mai scegliere tra studiare e sopravvivere.

«L’invio», questa volta, non è soltanto quello di una domanda universitaria.
È l’invio di una speranza — fragile, ma viva — verso un mondo che continua a credere nella luce.
Forse non possiamo cambiare il mondo intero,
ma possiamo scegliere di custodire intatta la nostra umanità.
Restare umani è il primo atto di rivoluzione.

Forse ogni invio è una preghiera laica:
che arrivi, che venga letta,
che qualcuno risponda.